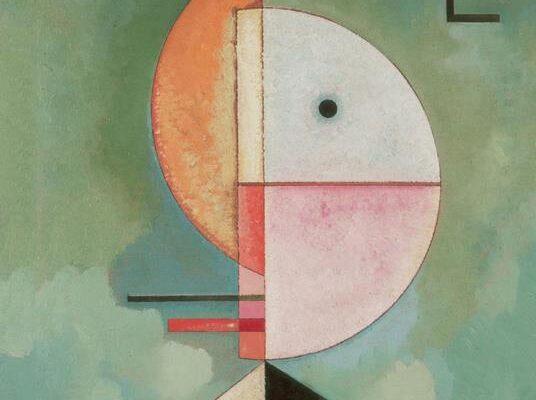Isteria di conversione e drammi del transgenerazionale: riflessioni a partir da un caso clinico

di Anika Fogli
In questo testo voglio proporre alcune riflessioni che nascono dal trattamento di una pre-adolescente con un grave, e invalidante, forma di isteria di conversione, giunta al trattamento psicoterapico dopo che in diversi ospedali erano state escluse altre forme di patologia che potessero spiegare i sintomi paretici che la ragazza presentava.
M.A. è una bambina proveniente dall’Europa dell’Est, di 12 anni, arrivata in Italia nel 2011 assieme alla madre, al fratello di 3 anni più piccolo, ai nonni materni. Il padre li ha raggiunti a distanza di 5 mesi circa per poi fare ritorno nel paese di origine poco tempo dopo.
M.A. ha difficoltà di deambulazione, dolori alle articolazioni, momenti in cui si blocca: la bambina non riesce a compiere atti normali, che coinvolgono l’uso volontario della muscolatura striata, come il camminare, prendere oggetti ed anche mantenere la normale postura. I numerosi accertamenti neurologici e medici effettuati nel paese di origine, per quanto riguarda i disturbi organici a carico del sistema nervoso centrale e dell’apparato locomotore, hanno dato esito negativo ed il disturbo è stato connesso a “cause psicologiche”.
Alcuni elementi del quadro presentato dalla bambina meritano una particolare riflessione per l’inquadramento diagnostico: la segnalata presenza di un atteggiamento quasi “indifferente” alla gravità della patologia, al dolore e alle conseguenze invalidanti, che si è manifestato durante le visite e gli accertamenti, dove la paziente poteva apparire anche sorridente e quasi distaccata dal dramma che viveva: condizione molto vicina a quello che gli autori storici descrissero come “bella indifferenza” delle pazienti affette da isteria di conversione, che si comportano come se se la gravità dei sintomi non le “toccasse” affettivamente ed autenticamente dal punto di vista psicologico. Inoltre è stato possibile notare come i sintomi di M.A. si modificassero a seconda delle persone che la esaminavano o che cercavano di muoverla, ulteriore conferma del forte peso della componente psicogena nella genesi del sintomo, e del rilievo relazionale dello stesso.
Il contesto culturale e famigliare in cui è calata la vicenda è a sua volta degno di nota. Il padre è risultato essere un uomo violento, sia con la moglie che con i figli ed in modo particolare con M.A. L’uomo, sia perché fortemente legato ad un modello culturale che vuole il maschio “forte” e dominante, sia per proprio volere, ha costretto la moglie a lasciare gli studi e a diventare subito madre, ostacolandola nella possibilità di essere donna, moglie e madre in un modo che fosse in sintonia con i suoi desideri, progetti e con la sua soggettività. La maternità non è stato il punto di arrivo di un cammino di maturazione personale e relazionale, e tantomeno la realizzazione di una aspettativa autentica: è stata “subita” come un dovere da compiere.
La mamma di M.A. è apparsa subito depressa, e ha riferito eventi subìti di significativo impatto traumatico. Fra questi in particolare un incidente domestico occorso al fratello minore, mentre era coinvolto in un gioco animato con M.A., e la madre si era solo brevissimamente allontanata. Durante tale gioco la paziente ha ferito “accidentalmente”, purtroppo in modo grave il fratello. E’ stato dopo tale episodio che, oltre alla depressione della mamma, sono comparse le manifestazioni di paralisi psicogena che, partendo dagli arti inferiori, si sono estese a tutto il corpo.
In questa storia di violenza, incidenti, costrizioni, annientamento della femminilità e coartazione rilevante della identità e della soggettività troviamo il drammatico emergere del sintomo di conversione, scacco doloroso per la tentata autorealizzazione ed emancipazione femminile.
La madre ha dovuto piegarsi alla volontà altrui (del marito “padrone” e della suocera che si è sostituita a lei come mamma nei primi mesi di vita di M.A., ponendosi come detentrice autoritaria di un sapere femminile che era inaccettabile mettere in discussione e modificare. La mamma di M.A. è stata costretta a sopportare violenze fisiche e psicologiche, e a vedere calpestata la propria possibilità di scelta in ambiti fondamentali della vita. Significativo è il modo in cui la mamma racconta la propria gravidanza. M.A. viene concepita 7 mesi dopo il matrimonio e la signora spiega inizialmente che: “Quando uno si sposa, la prima cosa che vuole sono i figli”. In un secondo momento però quando chiedo del secondo figlio, mi racconta che mentre M.A. è stata più voluta dal papà, il secondo è stato più voluto da lei: “Al mio paese si dice che devi avere figli appena ti sposi altrimenti le ovaie invecchiano… mah… là dicono così”. Questa convinzione-pregiudizio culturale, non proposta ma imposta, non sentita ma “eseguita”, ha privato la signora della propria libertà di scelta facendole vivere l’esperienza della gravidanza e della maternità come un imposizione a tratti intollerabile, violenta e usurpatrice della propria femminilità. La donna ha riferito come esperienza traumatica, con le parole “sono stata tagliata con le forbici”, l’episiotomia effettuata dalle ostetriche per agevolare il parto. E’ importante notare qui come tale tecnica oggettivamente finalizzata ad aiutare la donna, sia stata vissuta soggettivamente come una aggressione lacerante alla propria integrità fisica, come violazione profonda della propria immagine corporea. Ora che si trova in Italia, ed ha la possibilità di farlo, sembra che la signora voglia riscattarsi da tutto questo nel desiderio di realizzarsi e di offrire alla figlia un futuro diverso dal proprio. Ma il processo non è così semplice né immediato, e purtroppo non libero da sensi di colpa.
Spesso la mamma dice infatti di essere “stanca”: è come se per lei la vita fosse un peso caratterizzato dalla costrizione sociale e dalle aspettative altrui, vissute come una sorta di “corpo estraneo” incistato nell’apparato psichico, che schiaccia, pretende, sfrutta senza dare nulla in cambio, ma che si alimenta dei sensi di colpa che la signora prova a livello profondo, e che la spingono, come in passato, ad obbedire a tali istanze. In altri momenti, il desiderio di riscatto e di autoaffermazione, legati all’essere venuta ed al rimanere in Italia, si fanno avanti non vinti, alimentati da una lucida aggressività assertiva.
Il dialogo con la mamma di M.A. e la riflessione sui vissuti controtransferali da lei innescati, considerati insieme a ciò che accadeva fra me e la paziente e nel triangolo relazionale terapeuta-paziente-mamma mi ha portato alla seguente riflessione. La signora vive tesa fra la pressione a “fare” cose importanti come l’assunzione del ruolo di moglie e madre secondo i tempi ed i modi altrui, e l’ostacolo ad intraprendere cose da lei desiderate (come lo studio). Sente quindi dentro di sé quanto questo sia difficile da tollerare, fatica a mentalizzarlo e così proietta violentemente il proprio vissuto sulla figlia che si “blocca” esprimendo così una protesta, una opposizione dolorosa ma forte alle aspettative esterne. La complessa dinamica che conduce alla genesi del sintomo ha una forte componenente trans-generazionale. Sullo sfondo infatti vi sono: il desiderio del riscatto sociale e femminile che ha alimentato la spinta verso la migrazione in Italia, la aspirazione della mamma di riprendersi la propria vita e femminilità, la speranza che per la figlia il futuro sia migliore. Purtroppo però questi desideri sono ancora molto conflittuali, carichi di ambivalenza, di paure e gravati da oscure minacce: tutti questi elementi sembrano alimentare sintomi psicologici e psicosomatici di “blocco” quali quelli, purtroppo gravi ed invalidanti, mostrati da M.A. L’ambivalenza ed il conflitto sono aspetti che caratterizzano l’intera vicenda incastrando le due donne in un paradosso che le immobilizza e da cui pare davvero difficile uscire.
Da un lato c’è il desiderio che la situazione si sblocchi e che la ragazzina riprenda a camminare, dall’altro c’è invece il timore, qualora ciò si verificasse, della perdita dei vantaggi secondari (primo fra tutti la possibilità di rimanere in Italia e l’obbligato ritorno nel paese di provenienza. In una seduta M.A. mi riferisce non senza rabbia: “Non ci voglio tornare in..…..neanche la mamma vuole tornarci perché arrabbiata col papà”; aggiunge poi che, dal momento in cui il padre non vuole venire in Italia, lei non vuole tornare nel paese di origine. Una specie di arcaico, e molto aggressivo, “occhio per occhio e dente per dente”. La mamma è quindi terrorizzata dall’idea che la figlia guarisca ma, al contempo, sfinita dal vederla malata; se la prende allora con la bambina sentendosi poi in colpa. La donna è effettivamente gravata da una “montagna” di colpe: ha lasciato i figli da soli (nel drammatico episodio in cui M.A. ferì il fratello) e si è verificata la tragedia. Ha lasciato la “terra madre” e le tradizioni che vorrebbero le donne docilmente sottomesse. Ha lasciato il marito, cui aveva giurato fedeltà nel rito del matrimonio. Non riesce a nascondere la sua irritazione, intolleranza, rabbia per la condizione di M.A. e le rinfaccia il suo stato. Dentro di lei vi è un potente slancio verso la emancipazione, ma insieme si sente un mostro. La madre è una vittima (del “destino”, delle tradizioni schiaccianti, del marito violento) che vittimizza la figlia, e viene vittimizzata dalla patologia paretica di questa. Ecco quindi il paradosso doloroso: mantenere il sintomo e, contemporaneamente, non tollerarlo più. Vi sono, sia nella madre che nella figlia, tre forti nodi motivazionali: La aspirazione alla libertà e all’autonomia rispetto a tradizioni schiaccianti, luoghi opprimenti, figure violente (come il papà). La volontà di potere esprimere e realizzare il proprio Sé, la propria individualità, il proprio “Idiom”, usando le parole di Bollas. Il desiderio di “movimento”, psichico e fisico, come condizione per realizzare i due punti sopra esposti. A questi si oppone purtroppo, drammaticamente, una triade patologica: l’’esperienza pervasiva della violenza, subita, vista, temuta. Il peso di un “destino” particolarmente tragico, come l’incidente in cui da un banale gioco di bambini scaturisce l’evento per cui il fratello riporta una lesione grave e permanente. La gravosa presenza di una “colpa” profonda, radicale, paralizzante: la madre è “colpevole” di volere a tutti i costi la sua emancipazione, studiare, venire in Italia, sottrarsi al destino tradizionale; M.A. è “colpevole” perché con il suo blocco spacca la schiena agli altri, li costringe a occuparsi di lei. Entrambe, per azione per omissione, sono “colpevoli” dell’incidente accaduto al fratello. Il grande fantasma da affrontare è il rapporto fra movimento e senso di colpa: muoversi è percepito come colpevole e pericoloso. La paziente, durante un gioco irruento, ha ferito il fratello; la mamma, con la propria azione volta alla emancipazione, ha “distrutto” la famiglia, ha infranto regole antiche, ha interrotto la trasmissione trans generazionale dei ruoli e dei doveri. Il movimento di entrambe ha portato ad una catastrofe. Non si deve dimenticare inoltre che muoversi, e quindi guarire, comporta la perdita di benefici secondari. Nella loro mente la guarigione di M.A. equivale ancora troppo al ritorno nel paese di origine, un ritorno che tutte e due temono. Fino a un recente passato, la cultura patriarcale espressa in modo unilaterale escludeva le donne dalla possibilità di decidere i cambiamenti significativi, e tale cultura è ancora dominante e impressa nelle menti e nei corpi di che proviene dal paese di M.A. La paralisi da conversione è tipicamente femminile proprio per la difficoltà generata dalla tensione fra necessità di adeguarsi alla tradizione e desiderio di movimento, di accesso al nuovo. Per tali motivi è più comune nelle donne, o nelle figlie di donne che hanno più attivo dentro di sé tale “spinta” verso la possibilità di cambiare, come nello storico caso Anna O. di Freud1. La paralisi da conversione, inoltre, risulta oggi comparire in forma più drammatica nelle donne immigrate poiché il loro confronto con il nuovo e con il diverso si realizza con modalità più brusche ed estreme. Ci si allontana dalle proprie origini e radici, ci si ritrova gettate in una nuova cultura che, sebbene vista come migliore, è allo stesso tempo “altra”. Per M.A. e la mamma, la possibilità di lasciare la terra di provenienza dove ci si “deve” sposare giovani, generare subito e accettare le istruzioni della suocera, per andare in un paese in cui c’è la possibilità che i figli (comprese le femmine) vadano a scuola ed abbiano un futuro, porta con sé la speranza di un cambiamento, di un successo, di una liberazione da una cultura e da legami familiari costrittivi. Per questo la paziente non “può” guarire: perché né lei né la madre vogliono lasciare l’Italia. Si assiste, in questo come in altri casi di isteria di conversione, ad una reazione terapeutica negativa perché non si può, o non si vuole, guarire dalla dipendenza che è sì dolorosa ma anche rassicurante. La resistenza alla guarigione potrebbe essere il risultato dell’intreccio drammatico di un duplice conflitto, interiore e relazionale: a livello intrapsichico, come suggerisce Pontalis, la paziente “cerca, e allo stesso tempo rifiuta, la possibilità di farsi del bene, gioire della vita, di essere per sé una buona madre” (J. Pontalis, 1982). Questi soggetti rifiuterebbero di guarire per una sorta di auto-sacrificio: M.A. si sacrifica condannandosi ad essere portatrice del sintomo, per riparare le proprie colpe ed offrire alla madre l’opportunità di realizzare i propri sogni interrotti e di emanciparsi. A livello interpersonale e sociale, invece, la guarigione è desiderata, ma in modo conflittuale perché il sintomo consente di mantenere il vantaggio secondario di rimanere in Italia, appunto, per “curarsi”.
Quadri di questo tipo sono stati descritti anche quali espressione drammatica della presenza di “due menti in un corpo” (McDougall, 1990)2: i problemi relazionali della madre, le dinamiche familiari e i modelli transgenerazionali possono “incarnarsi” tragicamente nella paralisi isterica, alimentando un legame simbiotico fra madre e figlia. La dissociazione tra mente e corpo diventa un’importante difesa della diade e serve a mantenere lo stato di fusione; nella malattia vengono proiettati odio e aggressività ed il corpo diventa l’arena per l’espressione della sofferenza.
Ecco quindi che, nel lavoro terapeutico con la paziente, si è partiti da sintomi fisici per connetterli poi alla storia famigliare. La profonda scissione mente/corpo rendeva inaccessibili pensieri, emozioni, vita interiore che si esprimevano attraverso il linguaggio del corpo, un linguaggio da capire, interpretare e restituire facendolo divenire progressivamente “materia” che poteva essere sperimentata, sentita, pensata. Per arrivare a questo però, si è dovuto partire da dove la paziente esprimeva primariamente se stessa e la sua sofferenza: il corpo.
Bibliografia:
Bollas C.: Hysteria, Routledge, London – New York 2000
1 Freud S.: Studi sull’isteria, in Opere vol. 1, Boringhieri, Torino 1967
2 McDougall J., Teatri del corpo, Cortina, Milano 1990
Pontalis J. B., Laplanche J.: Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, Bari 2010.